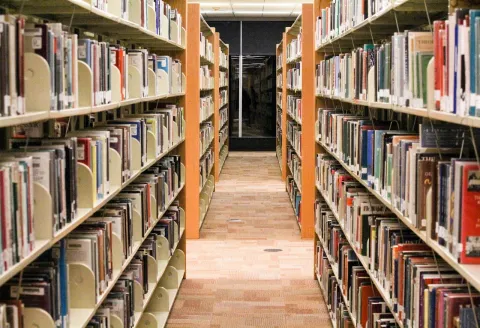
Abstract Eng
On June 10, 2025, the Advisory Section for Regulatory Acts of the Italian Council of State delivered the interlocutory opinion no. 561 on the draft implementing decree concerning the “significant contribution” introduced by Law n.o. 207/2024. In its opinion, the Council suspended the final approval of the draft due to serious procedural deficiencies, particularly the absence of the Regulatory Impact Assessment (RIA) and the Technical-Legal Analysis. The Council of State underlined that the RIA does not constitute a mere formal requirement, but rather an essential evaluative tool designed to assess the potential effects of the proposed regulation, substantiate the legislative choices made, and ensure their proportionality and internal consistency. Its omission, therefore, amounts to a substantive procedural defect which compromises the legitimacy, transparency, and effectiveness of the regulatory measure. Accordingly, the Council of State reaffirmed that, in the absence of the RIA, the regulatory process cannot be deemed complete nor capable of producing stable and lawful effects.
In mancanza di AIR, il Consiglio di Stato si limita a rendere un parere interlocutorio su una proposta di regolamento governativo
La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato è stata chiamata a pronunciarsi sullo schema di D.P.C.M., «regolamento recante la definizione del contributo di entità significativa a carico dello Stato in attuazione dell'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»; un intervento che si inserisce nel più ampio contesto delle misure volte al potenziamento dei controlli di finanza pubblica. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non poter formulare un parere definitivo, pronunciandosi invece con un parere interlocutorio[1] (n. 2025/00561), per la mancanza di due strumenti istruttori: l’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e l’Analisi tecnico-normativa (ATN). Come osserva il Collegio, «in assenza di tali fasi normativamente tipizzate del processo normativo, la “definitività” e, dunque, la stessa “stabilità” […] non possono ritenersi correttamente raggiunte».
Il ruolo cruciale dell’AIR nella costruzione delle norme
Rilevando la carenza dell’AIR, non sanabile in via implicita, il Consiglio di Stato definisce lo strumento come «la premessa “sociologica” e fattuale – misurabile nei suoi elementi compositivi nonché nelle correlazioni tra loro che possono determinare un impatto o un altro, tra quelli desiderabili nell’ambito della ratio della legge giustificativa dell’intervento (impatti idealmente altrettanto misurabili) - della successiva formulazione delle norme». In termini analoghi, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito la necessità che l’AIR sia predisposta in maniera adeguata e allegata agli schemi normativi (cfr. Cons. di Stato, sez. atti normativi, pareri: 2025/00634, 2025/00300, 2025/00560, 2025/00450, 2025/00574).
Ne deriva che l’AIR non vada considerata come un mero adempimento formale, in quanto strumento attraverso il quale l’amministrazione deve misurare ex ante gli effetti potenziali delle norme proposte, giustificare le scelte in relazione alla ratio legis, anticipare criticità applicative, valutare scenari alternativi e opzioni regolatorie, e infine selezionare la soluzione più proporzionata e coerente in relazione al contesto illustrato. La prassi applicativa, evidenziata dal Consiglio di Stato, si caratterizza invece per analisi troppo spesso ridotte a meri adempimenti burocratici, compilate a posteriori e con formule stereotipate, svuotate così del loro ruolo essenziale.
Nel parere in esame, il Collegio configura l’assenza dell’AIR quale eliminazione di un momento fondamentale di riflessione, indispensabile alla legittimità e alla qualità dell’azione regolatoria, senza la quale non è possibile effettuare una valutazione adeguata né della «congruenza e giustificabilità delle soglie quantitative di “significatività”» che giustificano l’intervento normativo, né della coerenza tra criteri soggettivi e oggettivi per l’individuazione dei contributi (vale a dire del relativo contenuto regolatorio).
In assenza dell’AIR, mancano inoltre gli elementi essenziali per apprezzare la razionalità dell’ambito di applicazione delle norme proposte (ad esempio, l’esclusione delle società a partecipazione pubblica quotate e delle loro controllate) e per verificare l’impatto potenziale della disciplina proposta sul contenimento della spesa pubblica. Un perimetro soggettivo eccessivamente ristretto, come quello prospettato, rischia infatti di determinare un esito contrario alla ratio legis, con conseguenze negative sulla finanza pubblica, ma ciò non è verificabile in assenza di AIR.
Il Consiglio di Stato fornisce anche importanti indicazioni sul procedimento regolamentare (non oggetto di analisi in questa sede), intervenendo in ordine a due profili fondamentali di diritto amministrativo: la natura giuridica del potere regolamentare[2] e la corretta attribuzione della titolarità dello stesso.
Verso una regolazione governativa responsabile e trasparente?
Dal parere del Consiglio di Stato emerge che l’AIR costituisce uno strumento di garanzia procedimentale la cui omissione non può essere considerata un mero vizio formale, ma rappresenta una frattura sostanziale nell’iter di formazione dell’atto normativo. Il messaggio alle amministrazioni è dunque chiaro: l’AIR non è un documento da allegare meccanicamente per chiudere il fascicolo, ma il presupposto conoscitivo dell’intervento normativo. Trattare l’AIR come un mero adempimento burocratico significa sottrarre alla regolazione la sua giustificazione sostanziale, ledendo i principi di legalità, buon andamento e trasparenza. In un sistema che intenda preservare coerenza e qualità della produzione normativa e della regolazione, l’analisi di impatto della regolamentazione non può essere considerata opzionale o rinviabile: senza di essa, il procedimento regolamentare non può ritenersi legittimamente concluso, né idoneo a produrre effetti durevoli e conformi alla volontà del legislatore.

Ferdinando Ioia, tirocinante presso il Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione NUVIR,
laureando LUMSA in diritto amministrativo
[1] Si tratta di una modalità consultiva che non conclude il procedimento, ma sospende il termine ordinario (di regola pari a quarantacinque giorni) previsto per il rilascio del parere, così da consentire l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In questo modo si promuove il confronto con l’amministrazione e si orienta il provvedimento verso una migliore definizione.
[2] In ordine alla natura giuridica, il Consiglio di Stato ricorda che la qualificazione di un atto come “regolamento” non può fondarsi unicamente su criteri formali, ma deve ancorarsi a parametri sostanziali quali l’astrattezza, la generalità e l’applicabilità ripetuta della disciplina. Come affermato, «gli indici qualificatori di un regolamento non sono soltanto di natura formale (…), ma anche di natura sostanziale», confermando così una lettura funzionale della potestà regolamentare, basata sugli effetti giuridici prodotti dall’atto più che sulla sua denominazione formale.
Submitted on Thu, 09/11/2025 - 08:36

